Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile
 Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile
Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile
Ennesima delusione per il Napoli di Calzona che non va oltre il pareggio in casa contro il Frosinone. I quattro goal sono tutti siglati da giocatori di proprietà del Napoli ma finisce 2-2. Meret e Osimhen sono croce e delizia di una squadra sempre più in difficoltà. continua la lettura….
Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia
 Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia continua la lettura….
Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia continua la lettura….
Tempesta di TikTok: Il Confronto tra Est e Ovest nell’Era Digitale
 Tempesta di TikTok: Il Confronto tra Est e Ovest nell’Era Digitale
Tempesta di TikTok: Il Confronto tra Est e Ovest nell’Era Digitale
Mala tempora per TikTok, su entrambe le sponde dell’Atlantico. continua la lettura….
Ruanda: a trent’anni dal genocidio una ferita aperta nella storia

Ruanda: a trent’anni dal genocidio una ferita aperta nella storia
Fu uno dei massacri più sanguinosi della storia, segnanti di un periodo oscuro. continua la lettura….
Caffè e sottolineature – recensione di “A schiovere”
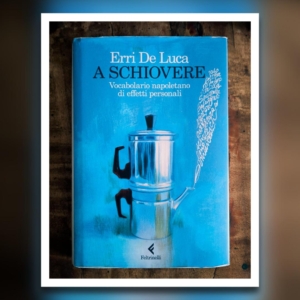 Caffè e sottolineature – recensione di “A schiovere”
Caffè e sottolineature – recensione di “A schiovere”
Una delle fortune che mi è capitata nella vita è stata sicuramente quella di crescere in una casa piena di libri, per cui ho sempre avuto qualcosa da leggere anche se non avevo dei soldi miei con cui comprarli. continua la lettura….
Intervista di Berardo Impegno a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. II parte.
 Intervista di Berardo Impegno a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. II parte. continua la lettura….
Intervista di Berardo Impegno a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. II parte. continua la lettura….
Donne che allattano cuccioli di lupo di Adriana Cavarero – Presentazione all’IISF
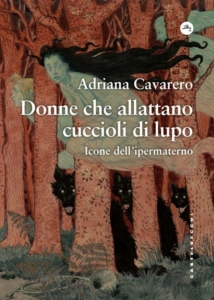
Donne che allattano cuccioli di lupo di Adriana Cavarero – Presentazione all’IISF
Lunedì 15 aprile, alle ore 17.30, sarà presentato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio) il libro di Adriana Cavarero – Donne che allattano cuccioli di lupo. Icone dell’ipermaterno (Castelvecchi, 2023). Sarà presente l’autrice. continua la lettura….
Conservatori alla riscossa
 Conservatori alla riscossa
Conservatori alla riscossa
In Irlanda si è celebrato un referendum che avrebbe dovuto aprire le porte a due modifiche della Costituzione del 1937. continua la lettura….
Monza vs. Napoli 2-4: agli azzurri bastano tredici minuti da Campioni d’Italia
 Monza vs. Napoli 2-4: agli azzurri bastano tredici minuti da Campioni d’Italia continua la lettura….
Monza vs. Napoli 2-4: agli azzurri bastano tredici minuti da Campioni d’Italia continua la lettura….



 L’Europa verso un futuro sostenibile, l’Italia si oppone.
L’Europa verso un futuro sostenibile, l’Italia si oppone.