Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile
 Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile
Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile
Ennesima delusione per il Napoli di Calzona che non va oltre il pareggio in casa contro il Frosinone. I quattro goal sono tutti siglati da giocatori di proprietà del Napoli ma finisce 2-2. Meret e Osimhen sono croce e delizia di una squadra sempre più in difficoltà. continua la lettura….



 Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia
Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia  Tempesta di TikTok: Il Confronto tra Est e Ovest nell’Era Digitale
Tempesta di TikTok: Il Confronto tra Est e Ovest nell’Era Digitale
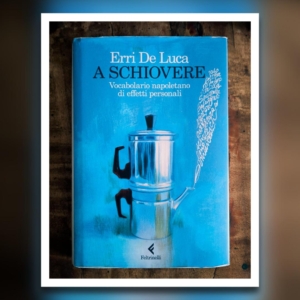 Caffè e sottolineature – recensione di “A schiovere”
Caffè e sottolineature – recensione di “A schiovere” Intervista di Berardo Impegno a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. II parte.
Intervista di Berardo Impegno a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. II parte. 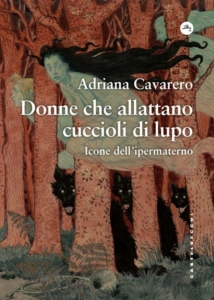
 Conservatori alla riscossa
Conservatori alla riscossa Monza vs. Napoli 2-4: agli azzurri bastano tredici minuti da Campioni d’Italia
Monza vs. Napoli 2-4: agli azzurri bastano tredici minuti da Campioni d’Italia 